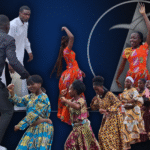Vangelo secondo San Luca 17,11-19
Lungo il cammino verso Gerusalemme, Gesù attraversava la Samarìa e la Galilea. Entrando in un villaggio, gli vennero incontro dieci lebbrosi, che si fermarono a distanza e dissero ad alta voce: «Gesù, maestro, abbi pietà di noi!». Appena li vide, Gesù disse loro: «Andate a presentarvi ai sacerdoti». E mentre essi andavano, furono purificati.
Uno di loro, vedendosi guarito, tornò indietro lodando Dio a gran voce, e si prostrò davanti a Gesù, ai suoi piedi, per ringraziarlo. Era un Samaritano. Ma Gesù osservò: «Non ne sono stati purificati dieci? E gli altri nove dove sono? Non si è trovato nessuno che tornasse indietro a rendere gloria a Dio, all’infuori di questo straniero?». E gli disse: «Àlzati e va’; la tua fede ti ha salvato!».
Rendete grazie e date gloria
Luis CASASUS Presidente delle Missionarie e dei Missionari Identes
Roma, 12 ottobre 2025 | XXVIII Domenica del Tempo Ordinario
2Re 5, 14-17; 2Timoteo 2, 8-13 ; Luca 17, 11-19
Il venerabile arcivescovo Fulton Sheen (1895-1979) affermava: Da un punto di vista spirituale, chi si vanta della propria intelligenza, del proprio talento o della propria voce, e non ringrazia mai Dio per essi, è un ladro; ha preso i doni di Dio e non ha mai riconosciuto il Donatore. (Way to Happiness, 1998). Questo spiega il lamento di Gesù nel vedere che solo uno dei lebbrosi guariti era tornato… Non voleva ricevere ringraziamenti; non ha mai detto nulla del genere. Ciò che lo rattrista è che gli altri nove non abbiano reso gloria a Dio.
Quindi, siamo invitati a riflettere su cosa significhi rendere gloria a Dio.
Non sembra facile, poiché se esaminiamo l’etimologia della parola “gloria” in latino, greco ed ebraico… vediamo significati molto diversi. Per di più, il concetto di “gloria” in questo mondo è piuttosto diverso, perché significa qualcosa che viene ricevuto, come un applauso o una lode.
A cosa si riferisce dunque Cristo oggi? Come possiamo rendere gloria a Dio?
Riflettendo la luce divina, la Sua azione in noi. Il Maestro lo aveva già espresso chiaramente: “Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, perché vedano le vostre opere buone e rendano gloria al Padre vostro che è nei cieli” (Mt 5,16). Cristo, pertanto, sente di aver reso gloria al Padre portando a termine fedelmente la missione affidatagli.
In questo modo, dare gloria a Dio significa dimostrare con le nostre azioni come portiamo avanti missioni che apparentemente ci superano, ma che dimostrano come tutto venga da Lui: Lui ci sceglie per una missione e ci dà la forza per compierla.
Per questo Cristo si arrabbiò quando vide che nove dei lebbrosi guariti non tornavano, per dare gloria a Dio, affinché, vedendoli, coloro che li conoscevano, si rendessero conto che il Signore li aveva visitati e che ora potevano vivere pienamente, con le loro famiglie, nella società, lavorando e contribuendo alla comunità.
Come ha ricordato Papa Francesco (17 mar 2024), la pienezza della gloria si è riflessa in Cristo non nei momenti dei suoi miracoli, e nemmeno nella Risurrezione, ma sulla Croce, per quanto sorprendente possa sembrare. Il fatto di poter vivere un abbandono totale, una pienezza di estasi, nonostante i nostri limiti, è manifestazione della gloria divina. Gesù stesso ha dovuto rinunciare a qualcosa della sua vita quando ha fatto del bene: dopo aver toccato i lebbrosi, per paura del contagio, non poteva più entrare pubblicamente in una città, ma rimaneva fuori, in luoghi deserti.(Mc 1, 45).
Perciò, quando vede avvicinarsi la sua fine, esclama in preghiera: Io ti ho glorificato sulla terra, compiendo l’opera che mi hai dato da fare (Gv 17, 4).
Nel testo evangelico odierno, è proprio un samaritano a riconoscere in Gesù la vera Via, la presenza divina che cambia la sua vita. Spesso accade che ciò che finisce per unirci (come la lebbra condivisa da samaritani ed ebrei) sia qualcosa di doloroso, ma la Provvidenza se ne serve per dimostrare che siamo veramente fratelli. In questa occasione, la risposta divina è sorprendente nella sua prontezza, perché, come dice il testo evangelico, quei lebbrosi, mentre se ne andavano, furono purificati. Altre volte, ci lamentiamo interiormente perché ci sembra che la Provvidenza non risponda mai…
Ma la verità è che lo Spirito Santo risponde immediatamente con uno dei suoi doni, e prima o poi, ne notiamo gli effetti nella nostra vita e, come abbiamo detto prima, non siamo più gli stessi. Ci sentiamo capaci di amare coloro che non ci amano; resistiamo persino a chiamarli “nemici” e riconosciamo in loro un’opportunità per testimoniare un perdono speciale, una prova d’amore che non possiamo dare con coloro che ci amano e ci comprendono.
Solo pochi anni fa, in un villaggio indiano dove era ancora in vigore il sistema delle caste, ci fu un’inondazione inaspettata e violenta. Diversi uomini della casta più bassa si avvicinarono a una donna di casta alta per aiutarla e portarla in salvo. Questa donna, che in altre circostanze non avrebbe permesso a nessuno di una casta inferiore di toccarla, ora dovette letteralmente salire sulle loro spalle per salvarsi.
—ooOoo—
Vediamo qualcosa di simile nella Prima Lettura, quando Naaman inizialmente rifiuta l’invito di immergersi nel fiume Giordano sette volte, ma alla fine lo fa. E ogni volta, vede che sta guarendo e anche il suo cuore guarisce, finendo per credere pienamente nel vero Dio e promettendo che il tuo servo non offrirà più olocausti o sacrifici ad altri dèi se non al Signore.
Questa è una lezione importante per noi: ogni volta che accettiamo la purificazione, sia essa suscitata dallo Spirito Santo o compiuta per nostra scelta, rinunciando ai nostri giudizi e al nostro orgoglio, Egli risponde con una grazia nuova, con un cambiamento nella nostra anima e nella nostra vita, che ci fa sentire che non siamo più gli stessi.
Nella Seconda Lettura, Paolo riflette appassionatamente su questa esperienza, vissuta nella sua stessa carne:
Se moriamo con lui, vivremo anche con lui; se con lui perseveriamo, con lui anche regneremo; se lo rinneghiamo, anche lui ci rinnegherà. Se manchiamo di fede, egli però rimane fedele, perché non può rinnegare se stesso.
Ripensando all’Antico Testamento, ricordiamo la storia di Giobbe, un uomo che viveva nella prosperità, era retto e temeva Dio; ma in una drammatica svolta degli eventi, perse i suoi beni, i suoi figli e la sua salute. Questa enorme sofferenza non fu una punizione, ma un mistero in cui seppe come entrare, e nel mezzo del dolore non maledice Dio, ma grida, si interroga e lotta con la sua fede.
I suoi amici vengono a confortarlo, ma finiscono per giudicarlo. Tuttavia, il dialogo che ne emerge, seppur teso, è una ricerca condivisa del senso della vita.
Giobbe osa dire a Dio: “Perché sei così crudele con me?” (Giobbe 7, 20). Il suo dolore lo porta a un rapporto più diretto e intimo con Dio, dal quale non riceve spiegazioni razionali, ma piuttosto gli rivela la Sua grandezza e vicinanza. Giobbe dice: “Ti conoscevo solo per sentito dire, ma ora i miei occhi ti vedono” (Giobbe 42,5).
Il Signore risana questo santo, ma la cosa più importante non è la guarigione materiale, bensì la profondità della sua eredità. Poi egli intercede per i suoi amici, dimostrando che la sofferenza lo ha reso più compassionevole, più vicino al prossimo.
Questo è il processo di ogni purificazione: Dio non manda alcun male, ma li usa tutti per avvicinarci a Lui e ai nostri simili. I lebbrosi, ebrei e samaritani, quando credevano di essere sani, quando si sentivano puri, si odiavano fino all’estremo, ma questa terribile malattia fu paradossalmente uno strumento che li portò insieme a rivolgersi a Cristo, implorando: “Gesù, Maestro, abbi pietà di noi!”. Lo chiamavano per nome, cioè considerandolo un amico, un fratello, qualcuno in cui veramente avevano fiducia. È un’altra lezione per te e per me, che siamo pieni di dubbi, che valutiamo se valga la pena fare tanti sforzi, avere tante contrarietà che NON ci danno un frutto immediato, visibile e consolante.
Una storia contemporanea. Nell’agosto del 2010, 33 minatori rimasero intrappolati a 700 metri di profondità nella miniera di San José, in Cile, dopo un crollo. Non avevano via d’uscita, erano isolati, con poco cibo e senza la minima idea se sarebbero stati salvati.
Per 17 giorni, nessuno in superficie seppe se fossero ancora vivi.
All’interno della miniera, questi uomini, di età, credo e personalità diverse, iniziarono a unirsi nella disperazione. Pregavano insieme, condividevano il poco cibo che avevano e si alternavano nella cura della lampada accesa, simbolo di speranza.
Uno dei minatori, Mario Sepúlveda, divenne una sorta di guida spirituale. Disse in un’intervista dopo il salvataggio: Laggiù eravamo in 34, non 33… perché Dio era con noi.
Finalmente, dopo 69 giorni di prigionia, furono salvati uno a uno, in un’operazione che commosse il mondo intero. Molti di loro dichiararono che la loro fede si era rafforzata e che la tragedia li aveva uniti come fratelli. Alcuni, non credenti, affermarono di aver iniziato a pregare per la prima volta nella loro vita.
—ooOoo—
Il Vangelo di oggi, che può sembrare lontano dalla nostra esperienza (lebbra, guarigioni miracolose, ecc.), deve essere tradotto nella vita di ognuno di noi. Persino il numero dei lebbrosi, 10, rappresentava nel mondo ebraico il numero del quorum, il numero di persone necessarie per una valida seduta della sinagoga; rappresenta, per noi, tutta l’umanità, tutti noi indeboliti dal peccato.
Ma questo brano del Vangelo non è solo una lezione di cortesia o di buone maniere. Si tratta di riconoscere che siamo continuamente perdonati, guariti dalla nostra mediocrità, o almeno invitati a seguire il cammino del cambiamento che ci conduce a una vita piena e condivisa, libera da false sicurezze. I dieci lebbrosi furono guariti, ma solo uno di loro, il samaritano, accettò la vera salvezza: “Alzati e va’, la tua fede ti ha salvato“, gli disse Gesù. Quella guarigione lo portò a “glorificare Dio a gran voce“, e i dieci guariti, a presentarsi davanti ai sacerdoti, per dare gloria a Dio almeno secondo l’antica e limitata forma della Legge.
Gesù sottolinea che l’unico che tornò con gratitudine era “uno straniero”, forse per mostrarci che questa capacità di estasi, di liberarsi da quella schiacciante sicurezza di sé, si trova in ogni essere umano. Prendiamo nota attentamente nel caso in cui dovessimo mai osare dire frettolosamente e dogmaticamente: Questa persona non crede in Dio, non ha alcun interesse per la vita spirituale.
______________________________
Nei Sacri Cuori di Gesù, Maria e Giuseppe,
Luis CASASUS
Presidente