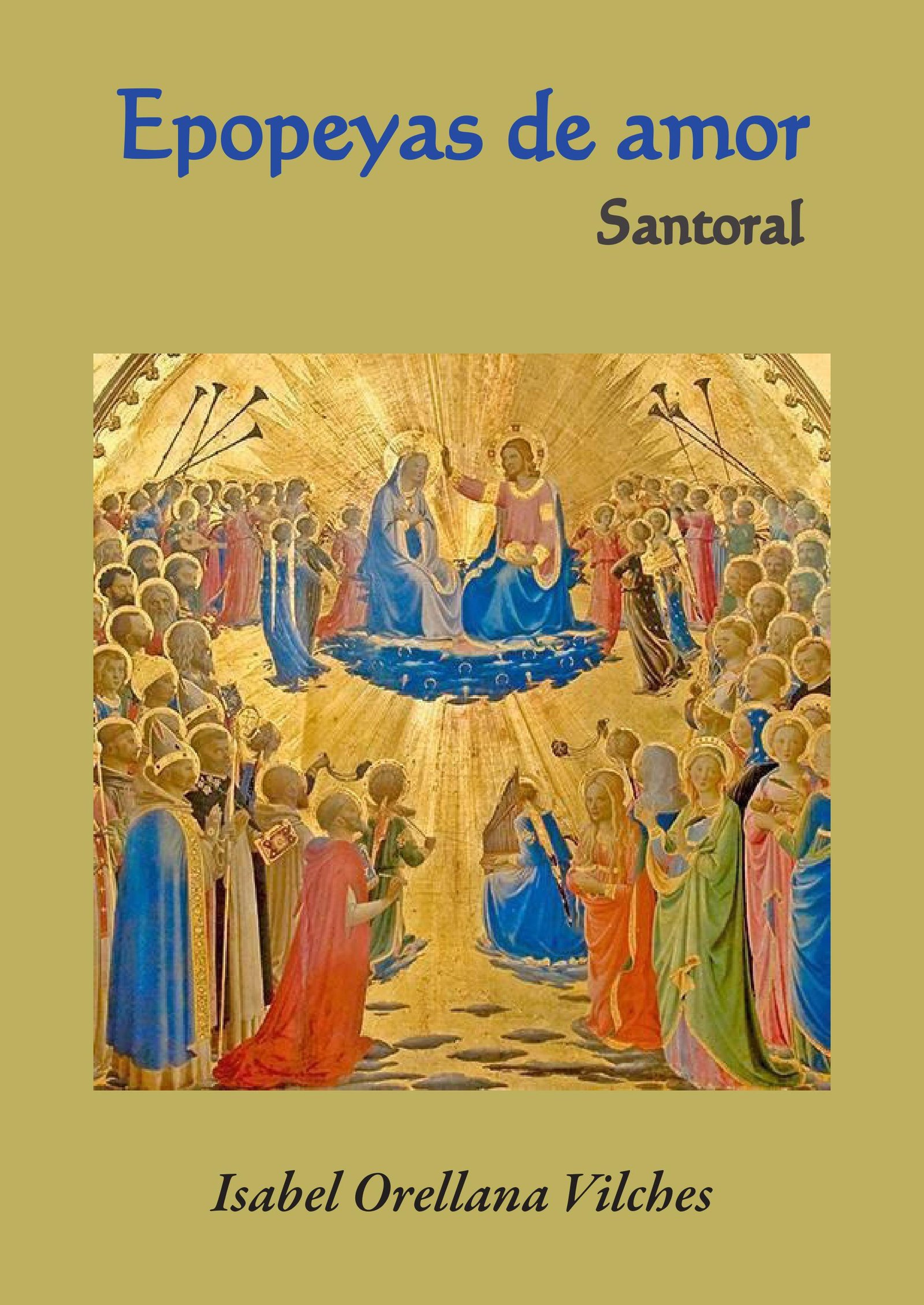“Fu un angelo nell’inferno. Bruciato d’amore per Cristo, per il quale volle soffrire ed essere disprezzato, non dubitò di donare la sua vita insieme ai lebbrosi di Molokai facendo di quel luogo, pieno di sfortune, un piccolo paradiso del cielo”.
Davanti alla sua vita ammutoliscono le parole. Perché questo grande apostolo della carità che non abbandonò i suoi amati malati, morì come loro dando una testimonianza di donazione commovente. Venne al mondo a Tremeloo (Belgio) il 3 gennaio 1840. Aveva un evidente vocazione per essere missionario. Nelle manualità infantili includeva in modo preferito la costruzione di case che ricordano quelle che occupano i missionari nella selva. Sua sorella e lui abbandonarono la casa paterna col fine di farsi eremiti e vivere in preghiera. Per la gioia dei suoi genitori, l’avventura finì quando furono scoperti da alcuni contadini.
Quando ebbe l’età sufficiente per lavorare, aiutò ad alleviare la malconcia economia domestica facendo lavori di costruzione ed edilizia. Sapeva anche coltivare le terre. Era un contadino, e quel nobile tratto si apprezzava nel suo modo di agire e di parlare. Aveva per abitudine il fare una visita al Santissimo ed un giorno, mentre si trovava nella sua parrocchia, ascoltò il sermone di un redentorista che diceva: “I piaceri di questo mondo passano presto…. Quello che si soffre per Dio rimane per sempre…. L’anima che si eleva a Dio trascina dietro di sé altre anime…. Morire per Dio è vivere veramente e far vivere agli altri”. Nel 1859 entrò nella Congregazione dei Missionari dei Sacri Cuori di Gesù e di Maria di Lovanio.
Ammirava san Francesco Saverio e gli chiedeva: “Per favore, ottienimi da Dio la grazia di essere un missionario come te”. L’occasione arrivò quando si ammalò suo fratello, il padre Pánfilo, religioso dello stesso Ordine che era destinato alle Hawai. Egli andava a sostituirlo. Poco tempo dopo il fratello guarì, favore per cui il santo ringraziò Maria nel santuario di Monteagudo. Quel giorno salutò i suoi genitori che non avrebbe più rivisto. Iniziò il viaggio nel 1863. Fu una traversata complicata. Dovette fare da improvvisato infermiere assistendo quelli che si ammalavano. Tra tutti i passeggeri fece attenzione specialmente al capitano della nave. Questi riconobbe che non si era mai confessato, assicurando che con lui sarebbe stato disposto a farlo. Damiano non poté soddisfarlo perché non era sacerdote, ma anni dopo lo avrebbe fatto in una situazione drammatica indimenticabile.
Fu ordinato a Honolulu. Poi, inviato in una piccola isola delle Hawai, la sua prima dimora fu una modesta palma. Lì costruì un’umile cappella che fu un angolo di cielo. Convertì quasi tutti i protestanti. Cominciò ad assistere i malati; portava loro le medicine e riuscì a restituire la salute a molti. In quella prima missione notò la presenza della lebbra, una malattia considerata maledetta, una conseguenza della quale era l’esilio. I malati del posto erano deportati a Molokai dove rimanevano completamente abbandonati alla loro sorte. Le loro vite, mentre duravano, andavano consumandosi in mezzo al marciume delle miserie e dei peccati. Informato Damiano dell’esistenza di quel gulag nel quale giacevano trascurate tante creature, pregò il suo vescovo monsignore Maigret che l’autorizzasse a convivere con loro. Il prelato, ancora scosso per la richiesta, glielo permise. Damiano non era un irresponsabile. Sapeva in anticipo quello che affrontava, e lasciò chiara l’intenzione che lo guidava: “So che vado ad un perpetuo esilio, e che presto o tardi mi contagerò con la lebbra. Ma nessun sacrificio è troppo grande se si fa per Cristo.”
Arrivò a Molokai nel 1873. Lo ricevette uno sciame di visi mutilati. Il posto, qualificato come un “vero inferno”, era inquinato da disordini e vizi diversi, droga per asfissia della loro disperazione. L’accolsero con allegria. Con lui un raggio di speranza attraversò da parte a parte l’isola. Non ci fu niente che potesse fare, e che lasciasse all’arbitrio. Aveva pensato a tutto. Mise in moto diverse attività lavorative e ludiche. Creò perfino una banda di musica. Con la sua presenza sparirono i malati abbandonati. Tutti li curava con pazienza ed affetto; insegnava loro regole di igiene ed ottenne che il posto, dopo tutto, fosse abitabile. Allo stesso tempo inviava lettere chiedendo aiuto economico che cominciò ad arrivare insieme ad alimenti e medicine. Era becchino, falegname delle bare e fabbricante delle croci che ricordavano i morti. Inoltre, faceva fronte ai temporali ricostruendo le capanne distrutte. Il trattamento coi malati era tanto naturale che li salutava dando loro la mano, mangiava nei loro recipienti e fumava nella pipa che gli tendevano. Stava portando tutti a Dio.
Le autorità gli proibirono di uscire dall’isola e di trattare coi passeggeri delle barche per evitare un contagio. Era da anni che non si confessava e lo fece in una lancia manifestando le sue mancanze gridando al sacerdote che viaggiava nella barca che conteneva le provviste per i lebbrosi. Fu la prima e l’ultima confessione che fece dall’isola. Un giorno notò che non aveva sensibilità nei piedi. Era il segno che aveva contratto la lebbra. Scrisse al vescovo: “Presto sarò completamente sfigurato. Non ho nessun dubbio sulla natura della mia malattia. Sono sereno e felice in mezzo alla mia gente”. Estrasse la sua forza dalla preghiera e dall’Eucaristia: “Se io non trovassi Gesù nell’Eucaristia, la mia vita sarebbe insopportabile”. Davanti al crocifisso, pregò: “Signore, per amore a Te e per la salvezza dei questi tuoi figli, ho accettato questa terribile realtà. La malattia mi andrà consumando il corpo, ma mi rallegra il pensare che ogni giorno in cui mi ritroverò più malato sulla terra, sarò più vicino a Te per il cielo.”
Quando la malattia si era estesa praticamente in tutto il suo corpo, arrivò una barca a capo della quale c’era il capitano che lo aveva portato alle Hawai. Voleva confessarsi con lui. Alla fine della sua vita fu calunniato e criticato da vicini e lontani. Egli supplicava: “Signore, soffrire ancora di più per il vostro amore ed essere ancor più disprezzato! “. Morì il 15 aprile 1889. Lasciava i suoi malati nelle mani di Marianne Cope.
Giovanni Paolo II lo beatificò il 4 giugno 1995. Benedetto XVI lo canonizzò l’11 ottobre 2009.
© Isabel Orellana Vilches, 2018
Autora vinculada a
![]()
Obra protegida por derechos de autor.
Inscrita en el Registro de la Propiedad Intelectual el 24 de noviembre de 2014.
________________
Diritti di edizione riservati:
Fondazione Fernando Rielo
Hermosilla 5, 3° 28001 Madrid
Tlf.: (34) 91 575 40 91 Fax: (34) 91 578 07 72
E-mail: fundacion@rielo.org
Deposito legale: M-18664-2020
ISBN: 978-84-946646-6-3